


Nel bestiario della settima arte, il richiamo più ancestrale spetta al licantropo che incarna la nostra ombra primordiale, l'essenza bestiale che si cela sotto la maschera della civiltà. A differenza del vampiro, aristocratico seduttore immortale, il licantropo rappresenta una trasformazione più viscerale e democratica: chiunque, dal più umile paesano al più distinto gentiluomo, può essere vittima della maledizione licantropica. Il cinema, già nei suoi primi anni, ha saputo catturare magistralmente questa dualità, fin da il Segreto del Tibet (Werewolf of London, 1935), film in cui Henry Hull incarnava la lotta tra razionalità vittoriana e istinto selvaggio. Ma è con l'Uomo Lupo (1941) di George Waggner che il genere getta le sue vere fondamenta: lo sceneggiatore Curt Siodmak e l'attore Lon Chaney Jr. donano al protagonista Larry Talbot una vulnerabilità tragica che trasforma il mostro in vittima del proprio essere, in ciò risuonando con un altro grande mostro classico: la Creatura di Frankenstein. In effetti, come osserva Leslie A. Fiedler in "Freaks", il licantropo cinematografico incarna perfettamente l'archetipo del "mostro simpatico", costretto a confrontarsi con una condizione che non ha scelto. Gli anni '80 furono "l'età dell'oro della trasformazione fisica", come li definì l'effettista Rick Baker: si pensi alla rivoluzionaria sequenza di mutazione corporea visibile in un Lupo mannaro americano a Londra (1981), pellicola che fuse spunto comico ad un orrore che ammodernava uno dei più classici fra i "classic monster" della Universal, in un modo che sfiorava il body horror; pensiamo anche alla metamorfosi psicosessuale de l'Ululato (1981), con la sua liberazione degli istinti repressi. Non è un caso, quindi, che Licantropia Evolution (Ginger Snaps, 2000) abbia brillantemente sovrapposto la licantropia alla metafora della pubertà femminile. D'altra parte, altre pellicole non hanno focalizzato la loro attenzione sul tema dell'istinto represso/liberato, ma hanno fatto della licantropia il terreno di altre metafore: Dog Soldiers (2002), ad esempio, ha preso la licantropia come spunto per esplorare i temi della fratellanza militare e della sopravvivenza. Resta interessante, del mito licantropico che ha contaminato anche il mondo del gaming (un esempio è the Quarry, 2022), non solo il fattore dell'istintualità liberata ma della ciclicità di essa, ovvero del fatto che sia immancabile che ciò avvenga: come la luna piena che inevitabilmente ritorna, il licantropo ci ricorda che sotto la nostra pelle civilizzata pulsa il richiamo selvaggio della natura ed esso non può rimanere nascosto a lungo.

Sembra si tratti di una sottocategoria del fantahorror troppo specifica e settoriale ma, in realtà, sorprende quanto siano i film, horror, thriller o anche semplicemente drammatici o comici, che vedono al centro dell'azione un medico o una figura sanitaria dalle cui azioni si generano conseguenze terribili o risibili. Il sottogenere Mad Doctor & Medical Horror, che affonda le sue radici nella letteratura gotica di Mary Shelley e nel suo immortale "Frankenstein" (1818) per poi evolversi in molteplici e disturbanti direzioni (Re-Animator, 1985), rappresenta una via maestra per l'esplorazione delle paure umane più viscerali, quelle legate al corpo, alla malattia e alla medicina stessa. Tangenziale al Body Horror, il Medical Horror vede, come detto, l'azione di uno demiurgo sovente folle - l'iconico Mad Doctor - che, per ragioni filantropiche o per manifesta perversione ( Aftermath, 1994), sfida le leggi di natura ma, in primis, quelle del buon gusto e della morale, fino a livelli di rappresentazione provocativi e disturbanti. Il fascino di questo sottogenere risiede anche nella sua capacità di sovvertire uno dei rapporti più sacri della società: quello tra medico e paziente. Film come l'Orribile segreto del Dr. Hichcock (1962) o il più recente the Human Centipede (2009), volendo citare due generazioni filmiche diverse, giocano proprio su questa violazione del giuramento di Ippocrate, trasformando il guaritore in carnefice; perdipiù, riflettono le nostre ansie contemporanee sulla direzione della ricerca scientifica e sul prezzo del progresso. In definitiva, questi film ci costringono a confrontarci con alcune delle nostre paure più ataviche: la perdita di controllo sul nostro corpo, il terrore della mutilazione, la vulnerabilità di fronte all'autorità (medica), il confine tra guarigione e dannazione che si fa sottile come una lama di bisturi.

Il mockumentary emerge come un esercizio di prestidigitazione narrativa per la quale la finzione si maschera da verità documentaristica con risultati che sottolineano, in primis, il fatto che il falso diventa vero. Come annotato anche per il genere Mondo, furono inaspettatamente i fratelli Lumière a dare il via ad una "dialettica tra autenticità e artificio" (Bill Nichols) tramite le loro "actualités", le quali, spesso, erano ricostruzioni in studio di eventi reali. Dal momento dell'invenzione del cinematografo, di fatto, si è posto un problema basilare: "l'assurdità intrinseca della ricerca dell'autenticità nell'era della riproduzione meccanica" (Vivian Sobchack). Sul versante horror, film quali the Blair Witch Project (1999) hanno dimostrato come il formato mockumentary possa essere utilizzato per amplificare l'effetto di terrore, adottando tecniche di ripresa che simulano i limiti della realtà: la telecamera tremante (effetto shacky cam), l'apparente spontaneità delle reazioni, il fuoco della ripresa che si perde, tutto per dare vita ad un simulacro di realtà. In un'epoca di "fake news" e "deep fakes", il genere assume una rilevanza ancora più profonda, diventando, paradossalmente, uno strumento per esplorare la natura stessa della verità mediatica. Forse è proprio questa la sua funzione più preziosa: ricordarci che ogni documentario, per quanto "vero", è sempre una costruzione, una narrazione, una scelta di cosa mostrare e cosa nascondere.

Il fenomeno dei Mondos e il suo esecrabile discendente, lo shockumentary, rappresenta l'interessante caso dell'impulso documentaristico che si fonde o, meglio, si contamina con il richiamo dell'exploitation. Come un Giano bifronte, questo peculiare sottogenere guarda simultaneamente alle nobili origini del cinema documentaristico e agli abissi più oscuri dell'intrattenimento sensazionalistico. Le radici dei mondo-movies affondano, inaspettatamente, nel terreno fertile del primo cinema dei fratelli Lumière. Quei pionieri furono tra i primissimi a comprendere il potenziale drammatico della realtà ricostruita, ricreando in studio eventi di cronaca per le loro "actualités"; un approccio che, con una certa ironia storica, anticipa di decenni le pratiche manipolatorie del cinema Mondo. Anni dopo, quindi, Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavara e Franco Prosperi, con il loro seminale Mondo Cane (1962) - ma in realtà ancora prima con Blasetti (Europa di notte, 1959) - codificarono involontariamente le regole di questo "nuovo" genere cinematografico. Il loro approccio, che miscelava sapientemente materiale autentico con sequenze orchestrate, creava una narrativa shock che si presentava come documento della realtà, pur essendo profondamente mediata dalla sensibilità exploitation; come nota il critico Rey Chow nel suo "Primitive Passions", questo tipo di cinema rappresenta una forma particolare di "violenza epistemologica", per la quale lo sguardo occidentale costruisce e consuma l'alterità attraverso il filtro della sensazione. Lo Shockumentary, evoluzione degenerata del Mondo Movie, porta questa tendenza alle sue estreme conseguenze. Film come Faces of Death (1978) di John Alan Schwartz, sotto lo pseudonimo di Conan LeCilaire, abbandonano ogni pretesa di indagine antropologica per abbracciare completamente la dimensione voyeuristica e sensazionalistica; la morte, la violenza e la devianza diventano merci da consumare, presentate con un'apparente oggettività che serve solo a mascherare la natura profondamente exploitation dell'operazione. Questa sezione, quindi, raccoglie pellicole specchio delle nostre pulsioni più oblique, tramite le quali il desiderio di conoscenza si confonde con il voyeurismo. Come suggerisce il pioniere negli studi critici sulla documentaristica Bill Nichols in "Representing Reality", questi film ci costringono a interrogarci non tanto sulla realtà che pretendono di documentare, quanto sul nostro rapporto con essa e sul nostro desiderio di consumarla attraverso lo schermo.

I monster-movies, anche detti creature features, sono film che vedono protagonoste creature fantastiche e sovente inquietanti che si fanno metafora di molte cose e molto diverse, passando da incarnazione dell'indomabile selvaggio in conflitto con la civiltà (King Kong, ad esempio), alle manifestazioni fisiche dei mondi liminali della società (come i mutanti di Chud, 1984), fino a creature che sono il risultato di esperimenti scientifici o che, persino diventano veicolo di una certa poesia o di un insospettato romanticismo o desiderio sessuale (le creature anfibie paiono molto adatte a questo: il Mostro della laguna nera, 1954; la Forma dell'acqua, 2017). Abbiamo anche i mostri generati: il Golem (1920) ha posto le basi per quella che David J. Skal definisce "l'estetica del mostruoso artificiale", un filone che trova la sua massima espressione in creature come il Mostro di Frankenstein, ma che si estende fino ai replicanti di Blade Runner (1982), mostri "umani, troppo umani" che mettono in discussione la nostra stessa definizione di mostruosità. Sottogenere di questa categoria, è quella dei Mostri Atomici (★), realtà filmica che sovente in intersezione con il fantascientifico, e che comparve in quella gloriosa epoca di paranoie nucleari e ansie ambientali che furono gli anni '50. Sintesi delle paure collettive inscritte nell'era della Guerra Fredda, gli Atomic Monsters emersero con prepotenza nel 1954; due sono le pellicole che ne segnano l'esordio e che rimangono, tuttora, fra i più fulgidi esempi del genere: Assalto alla Terra (Them!) e Godzilla (Gojira). Soprattutto quest'ultimo diverrà re indiscusso dei mostri giganti kaiju nipponici (letteralmente, strana bestia), emergendo dalle profondità dell'oceano come una metafora ambulante e distruttiva del trauma nucleare giapponese post-bellico. Ma ricordo che anche gli umani potevano essere mostri atomici (the Cyclops, 1956). Con l'affievolirsi della minaccia nucleare, parallela alla distensione fra USA e URSS, l'ansia atomica andò a mutarsi in ansia ambientale relativa ad inquinanti vari: non sono più le nazioni a determinare il dissennato inquinamento radiattivo ma, in era capitalista, sono le aziende, le corporazioni e le multinazionali a malversare ai danni del pianeta per ottenere profitti sempre più sostanziosi. L'eco-monster ( ★), generalmente, trova la sua migliore collocazione fra il Natural Horror e il Body Horror per l'impatto che ha sugli animali resi aggressivi dalle tossine - ma nella realtà resi solo morti a causa dell'inquinamento! - e sul corpo umano che si fa tela per esprimere le colpe di una società poco attenta all'ambiente. Esempio paradigmatico, un classico di serie-B come C.H.U.D. (1984), che vede i rifiuti tossici trasformare i senzatetto (rifiuti sociali) di New York in mutanti cannibali. Il monster-movie contemporaneo continua a reinventarsi, ed è proprio questa sua capacità di evolversi insiema alla società che rende questo genere eternamente giovane rimanendo fedele alle sue radici spettacolari ma sapendo, al contempo, porsi come specchio critico del presente, non dimenticando che il monster-movie come genere, perlopiù, come ha osservato acutamente Susan Sontag nel suo "The Imagination of Disaster", rappresenta "l'estetica della distruzione elevata a spettacolo sublime". Si segnala, infine, che in questa specifica sezione non sono presenti i mostri annoverabili nel Natural horror (quindi gli animali assassini), i mostri classici (Vampiri, Licantropi, Mummie, Frankenstein vari), e le creatue demoniache; a tutte queste categorie è dedicata una specifica sezione.

Se si tratta di mumblecore horror, come perlopiù qui in elenco, si tratta di un'interessante intersezione tra il minimalismo "slice-of-life", una fetta di vita, tipico del movimento mumblecore e le convenzioni del cinema del terrore, specchio anche, ma non solo, di una democratizzazione della produzione filmica che ha fatto dei limiti di budget una risorsa espressiva. Il termine "mumblecore", coniato quasi per scherzo durante il South by Southwest Festival del 2008, ha trovato la sua consacrazione horror con film come a Horrible Way to Die (2010) di Adam Wingard, pellicola nella quale l'effetto shacky-cam e i dialoghi improvvisati tipici del mumblecore si fondono con una narrazione dark che J. Hoberman ha definito "intimamente apocalittica"; un'estetica della tensione in cui il terrore si annida nelle pause, nei silenzi, nelle conversazioni apparentemente banali. Il mumblecore horror, dimensione intermedia fra una rappresentazione il più naturale possibile e il soprannaturale, ha il suo punto di forza nella sua capacità di inserire l'orrore in un contesto di quotidianità millennials, in cui, come nota lo sceneggiatore Nick Pinkerton: "i mostri emergono tra una conversazione su Tinder e un caffè biologico". Opere come Creep (2014) di Patrick Brice rappresentano perfettamente questa tendenza, utilizzando l'intimità forzata tipica del mumblecore per creare un horror dell'imbarazzo elevato a terrore esistenziale. Il sottogenere continua a evolversi, come dimostra We're All Going to the World's Fair (2021), film in cui la sensibilità mumblecore si fonde con l'horror digitale per dare a un ritratto della solitudine nell'era social. È proprio questa capacità di coniugare l'intimità lo-fi con il terrore psicologico che rende il mumblecore horror un fenomeno culturalmente significativo. In questo elenco troveranno spazio non solo i film mumblecore "universalmente" riconosciuti come tali, ma anche le pellicole nelle quali il dialogo fra soggetti, per quantità e stile, diventa variabile fortemente caratterizzante, come ad esempio si assiste, in genere, nei film di Tarantino.

Il risveglio, fra polvere e bende, delle mummie cinematografiche occupa una nicchia peculiare sospesa tra l'archeologia coloniale e il romanticismo macabro. Come osserva Christopher Frayling nel suo "The Face of Tutankhamun" (1992), la mummia cinematografica emerge come perfetta sintesi tra il fascino occidentale per l'egittologia e l'inquietudine verso l'appropriazione culturale dei tesori antichi. La pietra miliare del genere, la Mummia (1932) di Karl Freund, con protagonista un magnetico Boris Karloff, stabilisce quello che il professor Andrew Tudor definisce il paradigma della "vendetta archeologica": la hybris dello scienziato occidentale che si scontra con forze millenarie incomprensibili che paiono incarnare la colpa stessa di un Occidente predatorio; si tratterebbe di uno specifico sottogenere, quello dell'horror archeologico, nel quale le tombe violate diventano, appunto, metafora dell'imperialismo. È interessante notare anche come il personaggio di Imhotep anticipi di decenni quella che Edward Said chiamerà "Orientalismo", ovvero un sistema di rappresentazione occidentale dell'Oriente basato su stereotipi e dinamiche di potere coloniale, con un mostro esotico che è simultaneamente minaccioso e seducente. Gli anni della Hammer vedono una brillante reinvenzione con la Mummia (1959), in cui Christopher Lee infonde alla creatura "una dignità tragica che trascende il makeup" (David Pirie). Con ironia, poi, il genere si è evoluto dal dramma gotico ad una dimensione action non priva di ironia, come testimonia la Mummia (1999) di Stephen Sommers, una combinazione fra l'avventuroso alla Indiana Jones e altre pellicole chiaramente più orrorifiche connesse al soprannaturale, con anche spruzzatrina di romanticismo per rendere lo spettacolo complessivo più "rotondo" al palato del pubblico mainstream. Non mancano interessanti variazioni sul tema, come l'inquietante Bubba Ho-tep (2002), film nel quale una mummia si aggira in una casa di riposo del Texas; una brillante meditazione sulla vecchiaia. Da'ltronde, la mummia è un mostro peculiare, forse di non troppo appeal, che, però possiede questa sua peculiarità rispetto agli altri mostri del cinema: rappresenta sia la morte sia il suo superamento, ma si fa anche portatore di un amore che attraversa i millenni, rendendolo una grande tragica figura post-romantica.

Una nicchia cinematografica, qui su Exxagon non molto abitata, che, tuttavia, conferma come il cinema weird e horror non conosca registri espressivi interdetti: quando l'incubo si mette a cantare, il risultato può essere tanto ridicolo quanto geniale, ma (quasi) mai noioso. Un ibrido tanto raro quanto affascinante, un ossimoro cinematografico che trasforma il terrore in melodia e la morte in coreografia. Questa sezione, sparuta come un coro di fantasmi, raccoglie quelle pellicole che osano miscelare sangue e note, trasformando il genere in qualcosa di inaspettatamente lirico. Il musical horror è un territorio di frontiera, in cui registi come Brian De Palma, Lloyd Kaufman o Tim Burton hanno dimostrato che anche l'orrore può essere melodioso. Peraltro, un genere che, per molti è già orrore in sé, in quanto insopportabile!

Il mystery, tra ombre e rivelazioni, è uno dei generi da sempre più apprezzato dal pubblico, forse perché, come osservato da Raymond Chandler creatore del detective Philip Marlowe: "il mistero non è un gioco matematico ma un testimone della nostra insaziabile curiosità per l'inspiegabile". A partire dal seminale il Gabinetto del dottor Caligari (1920), vertiginosa discesa nell'inconscio e il primo vero thriller psicologico, il cinema mystery ha saputo trasformare l'incertezza in arte. Dopo il quintessenziale i Diabolici (1954) di Clouzot, il mystery assurge a genere di enorme popolarità grazie ad Alfred Hitchcock, uno dei maestri indiscussi della suspense, che con la Donna che visse due volte (1958) ha elevato l'investigazione a una forma di ossessione esistenziale, film che portano i protagonisti delle storie, e con loro gli spettatori, ad un piano di analisi psicologica. Il genere si nutre di quella particolare alchimia tra il visibile e l'invisibile, tra ciò che viene mostrato e ciò che viene sapientemente celato. Non è un caso che la critica Laura Mulvey vedesse nel mystery: "la più metacinematografica delle forme narrative, in cui l'atto stesso del vedere diventa oggetto di investigazione." Il mystery contemporaneo ha saputo certamente reinventarsi se pensiamo a pellicole quali Cena con delitto - Knives Out (2019), film in cui Rian Johnson gioca con i tropi del genere, o Mulholland Drive (2001), con il quale David Lynch trasforma Los Angeles in un enigma onirico che sfida ogni tentativo di soluzione univoca. E ogni giallo, al di là dell'approccio e della storia, invita a risolvere l'enigma più grande, quello della natura umana. In questa categoria sono segnalati i gialli o gialli-thriller o sexy-gialli della tradizione italiana, i quali trovano un loro specifico spazio nella sezione Spaghetti Giallo e Thriller.

Il bestiario cinematografico non sarebbe completo senza il riconoscimento del sottogenere Natural Horror, ovvero il ricco filone delle pellicole che trattano di creature viventi, perlopiù animali (da cui anche la definizione di Animal Horror) più o meno impazziti, più o meno giganti, più o meno disgustosi che attantano alla vita di noi umani; rappresentazione delle nostre ataviche paure verso il regno animale combinate con le ansie contemporanee sulla fragilità dell'equilibrio ecologico. Pur con antecedenti eccellenti (gli Uccelli, 1963; Fase IV: Distruzione Terra, 1974), il Natural Horror raggiunge il suo apice negli anni '70, quando lo Squalo (1975) di Spielberg codifica magistralmente le regole di quella che diventerà una vera e propria ossessione cinematografica. Il successo del film di Spielberg genererà una proliferazione di imitazioni di questi film che trattano di una natura che si rifiuta di essere dominata dall'uomo, epigoni che spaziano dal sublime al ridicolo: dai piranha di Joe Dante (Piranha, 1978), sorta di parodia che Roger Corman trasforma in commento sulla paranoia post-Vietnam, fino al plantigrado di Grizzly l'orso che uccide (1976) soprannominato, non a caso, "Jaws with Paws", lo squalo con le zampe, per poi approdare allo sharkploitation più poveristico prodotto dalla the Asylum (Sharknado, 2013). Il Natural Horror gioca spesso con quello che John Berger chiama "lo sguardo non ricambiato" tra umano e animale: che si tratti di coccodrilli, serpenti o ragni, queste creature rappresentano l'alterità assoluta, immune al nostro tentativo di antropomorfizzazione. Non è un caso che molti di questi film si svolgano in luoghi liminali - laghi, foreste, deserti - dove la presunta supremazia umana viene messa in discussione con risultati spesso sanguinari e, occasionalmente, esilaranti. La varietà animale ha consentito l'indicazioni di sottogeneri nel sottogenere: croc-movie (★), insetti e aracnidi o killer-bug movie (★), animali marini (★), vermi, molluschi e parassiti (★), mammiferi (★), volatili (★), sharkploitation (★), rettili e anfibi (★), roditori (★), piante (★). Linneo è servito.
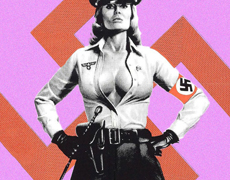
Genere controverso della cinematografia exploitation, anche noto come

Settore tematico particolarmente inquietante che s'addentra in uno degli angoli più oscuri della psicopatolohgia umana. Il cinema della necrofilia rappresenta il definitivo ed estremo punto di contatto fra Eros e Thanatos, un territorio in cui, come osserva Julia Kristeva nel suo seminale "Powers of Horror" (1980), "il desiderio oltrepassa i confini non solo della moralità, ma della stessa natura umana". Questo peculiare filone cinematografico ha esplorato diverse sfaccettature di quella che la psichiatria classifica comprensibilmente come una delle più estreme parafilie, una dimensione psichica, per citare il professor Robert Kastenbaum, nella quale: "la pulsione sessuale si fonde paradossalmente con il suo opposto ontologico". D'altra parte, il cinema raramente ha fatto della necrofilia uno studio serio e competente ma, anzi, questo quartiere dell'horror è diventato rifugio di narrative sensazionalistiche, obliquamente erotiche o anche ultragore, con la spettacolarizzazione di uno dei tabù più estremi. Dal poco visto Necrophagus (1971) di Miguel Madrid, a Kissed (1996) della Stopkewich, da la Necrofila (1972) di Lacerte, che Robin Wood identificò come "un tentativo di Hollywood di commercializzare l'incommercializzabile", al nichilismo brutale di Aftermath (1994), il cinema dell'amore d'oltretomba oscilla tra due poli opposti: da un lato il tentativo di rendere l'inaccettabile quasi poetico, trasformando una patologia in una love story grim-dark dai toni romantici; dall'altro, il desiderio di dare forma cinematografica all'abiezione ultima, quella che sfida non solo la morale ma la natura stessa del desiderio umano. Qui, qui, il desiderio si traforma in cinema dell'orrore, e si viene a creare un territorio periferico nel quale le convenzioni narrative tradizionali si dissolvono di fronte all'impossibilità stessa del loro oggetto.

Nato dalle ceneri dell'espressionismo tedesco - si pensi ad M - il Mostro di Dusseldorf (1931) di Lang come a un inquieto padre fondatore - e nutrito dalla letteratura hard boiled di Hammett e Chandler, il noir è quel mondo disegnato con atmosfere cupe e pessimistiche, trame intricate, antieroi tormentati e moralmente ambigui; si tratta di film che esplorano il lato oscuro dell'umanità, spesso ambientati in città plumbee e piovose, dove il crimine e la corruzione regnano e i protagonisti sono spesso investigatori privati, criminali o semplici cittadini, travolti da eventi più grandi di loro, che lottano per sopravvivere in un mondo senza speranza. In effetti, pur con le sue ricorsività narrative e scenografiche, il noir non è tanto un genere quanto uno stile, un modo di guardare a un mondo in cui si consuma l'eterno dramma della corruzione umana, un mondo di antieroi alla Humphrey Bogart che camminano sul filo del rasoio tra redenzione e dannazione. Nel fumoso universo noir, la catalogazione dei sottogeneri rappresenta un esercizio tanto affascinante quanto scivoloso. Il tech-noir, utilizza elementi di fantascienza e tecnologia per creare atmosfere distopiche e alienanti; esempio paradigmatico, Blade runner (1982). Il neo-noir reinterpreta il genere classico in chiave moderna, con uno stile visivo più curato e una maggiore complessità narrativa: Seven (1995) e Memento (2000) sono thriller certamente neo-noir. Il sopracitato genere Hard Boiled (★) si caratterizza per protagonisti cinici, duri e senza scrupoli, immersi in un mondo violento e senza speranza, più inclini all'azione che alla narrazione. Si potrebbe, quindi, intendere l'hard boiled come la versione più cruda e cupa del noir, ma, per essere più precisi, l'hard boiled è il precursore (letterario) del noir, il quale, nella sua forma classica (anni '40-'50) traduce i temi della letteratura di Dashiell Hammett ("Il falcone maltese", 1930) e Raymond Chandler (i romanzi di Philip Marlowe) aggiungendovi una quota psicologica ed una stilistica, quei ben noti chiaroscuri espressionisti e le atmosfere un po' oniriche. Se, per citare i classici, "il Grande sonno" (1946) di Howard Hawks è la quintessenza di questo approccio, col suo cinismo hard boiled preso da Chandler ma avvolto dall'estetica noir, esempi più moderni possono essere rappresentati da Sin City (2005), un neo-noir hard boiled; film come Angel Heart - Ascensore per l'inferno (1987) e Constantine (2005), invece, sono hard boiled interpolati con l'horror. Altri sottogeneri riconosciuti nell'alveo del noir sono: il poliziesco procedurale, in cui la macchina investigativa diventa protagonista assoluta (la Città nuda, 1948); l'Heist Film anche detto Caper Movie, in cui il crimine perfetto si trasforma invariabilmente in una discesa agli inferi (Giungla d'asfalto, 1950); il Wrong Man Noir che vede un innocente intrappolato in una spirale di eventi fuori dal suo controllo (Due ore ancora, 1949); il Doomed Love Noir in cui la passione diventa una condanna a morte (Brivido Caldo, 1981); infine, il Social Problem Noir in cui il crimine diventa lente d'ingrandimento sui mali della società (Forze del male, 1948). Categorie, comunque, facilmente sovrapponibili e capaci di creare ibridi affascinanti.

Sposa di Cristo, certo, ma la fedeltà coniugale è cosa dura! Controversa sottocategoria dell'exploitation che emerge dall'intersezione tra il cinema gotico italiano e la provocazione erotica tipica del periodo. Il nunsploitation ha avuto il suo picco di popolarità negli anni '70, quando molti registi hanno sfruttato l'iconografia religiosa per creare storie audaci e provocatorie, non a caso in una fase storica di grande contestazione nei confronti delle istituzioni, fra le quali la Chiesa, l'istituzione millenearia occidentale. I film di questa categoria spesso presentano suore come figure seducenti e tormentate, coinvolte in relazioni proibite con sacerdoti, demoni o altri personaggi ambigui, il che implica scene di nudo e violenza. L'ambientazione conventuale diventa un microcosmo asfittico in cui si manifestano tensioni represse, dinamiche di potere e conflitti psicologici. I conventi rappresentati in questi film divengono spazi liminali dove sacro e profano si contaminano reciprocamente, il tutto filtrato attraverso la sensibilità exploitation che, il più delle volte, non perdeva troppo tempo in sottiglezze di rappresentazione e svolazzi intellettuali. Registi come Walerian Borowczyk, Ken Russel e Joe D'Amato hanno saputo trasformare questo sottogenere in un veicolo per esplorare tematiche anche sorprendentemente complesse: il rapporto tra spiritualità e corporeità, l'autoritarismo istituzionale e la repressione sessuale come metafora politica. Ecco perché questi film, pur nella loro natura exploitation, offrono inaspettati spunti di riflessione sulla condizione femminile e sul potere istituzionale, temi che paiono non diventare mai desueti.

Il fascino delle grandi magioni oscure e sinistre è innegabile e, certo, esse hanno stregato la fantasia letteraria e quella degli sceneggiatori fin dagli esordi. L'Old Dark House è una peculiare declinazione del gotico che trasforma dimore vittoriane e manieri decadenti in veri e propri personaggi, protagonisti silenziosi di incubi filmici. Pur se le sue radici affodano nella letteratura gotica, l'Old Dark House si eleva a vera e propria arte delle ombre grazie al cinema. il Castello degli spettri (1927) rappresenta, forse, la quintessenza di questa prima età dell'oro del genere: ereditiere terrorizzate, ospiti inquieti e sinistri maggiordomi danzavano un balletto macabro tra corridoi scricchiolanti e passaggi segreti. La formula si è evoluta nel tempo con una versatilità sorprendente: dalla commedia horror il Fantasma di mezzanotte (1939), fino all'elegante decadenza de gli Invasati (1963) di Robert Wise, in cui la Hill House di Shirley Jackson diventa un labirinto psicologico di desideri inespressi e repressi. Il filone ha conosciuto interpretazioni memorabili anche in chiave post-moderna: Crimson Peak (2015) di Guillermo del Toro è un omaggio appassionato al genere che trasforma Allerdale Hall in un organismo vivente che sanguina argilla rossa abitato da spettri testimoni silenti di tragedie passate, mentre The Others (2001), ormai un classico, ribalta magistralmente le convenzioni del ghost story ambientato in grande dimora con un twist che, come nota David Bordwell, "ricodifica retroattivamente ogni scena del film". Come suggerisce Barbara Creed nel suo "The Monstrous-Feminine", offrendo una lettura femminista, tuttavia coerente con le idee psicanalitiche relative alla simbologia onirica relativa alla casa e alle stanze, queste dimore maledette rappresentano uteri architettonici che partoriscono i nostri incubi più reconditi; non è un caso che registi contemporanei come Ari Aster (Hereditary, 2018) continuino a trovare nella casa, intesa nel suo senso più esteso di famiglia, un potente veicolo per esplorare traumi e orrori ancestrali.

Il firmamento cinematografico orientale brilla di una luce particolare che oscilla tra la raffinatezza più estrema e la più selvaggia brutalità grafica. Come osserva Donald Richie in "Japanese Cinema: Film Style and National Character", il cinema dell'Estremo Oriente ha sviluppato un linguaggio proprio, tramite il quale gli archetipi occidentali vengono continuamente decostruiti e riassemblati in forme inedite e spesso sconcertanti. Dal minimalismo spettrale di Kwaidan (1964) di Masaki Kobayashi - in cui il soprannaturale si manifesta attraverso una stilizzazione quasi teatrale - fino all'ipnosi digitale di Ringu (1998), il cinema nipponico, e con esso quello dell'estremo oriente, ha saputo trasformare le proprie antiche leggende in incubi perfettamente calibrati per l'era della riproducibilità tecnica. Pellicole catalogate come eroguro, o il softcore Pinku_eiga, i Cat III di Hong Kong, il K-horror, il bizzarro essai di cineasti come Sion Sono hanno trasformato l'eccesso in forma d'arte, spingendo i confini del cinematograficamente accettabile verso territori inesplorati ma anche verso un horror raffinato, psicologico e silnzioso che Kim Newman chiama "la nouvelle vague dell'horror asiatico". Si tratta di un universo in continua espansione che, come il principio dello yin e yang, trova il suo equilibrio proprio nella coesistenza degli opposti, passando da pellicola la cui visione potrebbe e dovrebbe essere sollecitata per tutti, ad altre la cui visione è consigliata ad un ristretto manipolo di spettatori col coltello in bocca. Questa la legenda dei paesi orientali nello specifico: Giappone (★), Corea del Sud (★), Hong Kong (★), altri paesi orientali: Thailandia, Filippine, Malesia, ... (★).

Il film omnibus, ad episodi o "portmanteau", come venne battezzato dalla critica britannica degli anni '60, rappresenta uno dei più intriganti esperimenti di storytelling cinematografico che ha trovato terreno particolarmente fertile nel cinema horror. Esso presenta una serie più o meno ampia di episodi disgiunti l'uno dall'altro tematicamente ma connessi da una storia di contorno, la wrap-around story, che inpacchetta il film nel suo complesso. Pur con dei precedenti (es. il Gabinetto delle figure di cera, 1924), il capostipite di questa tradizione può essere considerato Incubi notturni (1945) degli Ealing Studios, un gioiello del cinema britannico che narra di un architetto intrappolato in un incubo ricorrente; questa la storia che fa da cornice a una serie di racconti soprannaturali. La Amicus Productions, sotto la guida di Milton Subotsky e Max Rosenberg, ha poi elevato il formato a vera e propria arte con film come le Cinque chiavi del terrore (1965) in cui Peter Cushing e Christopher Lee si alternano come maestri di cerimonie dell'orrore. Come fa notare Kim Newman in "Nightmare Movies", il portmanteau horror riflette la natura stessa delle storie di paura: frammentarie, febbrili, simili a incubi che si susseguono in una notte insonne. Non è un caso che Mario Bava, con il suo I tre volti della paura (1963), abbia creato quello che Dario Argento definisce "un caleidoscopio di terrore puro" in cui ogni episodio esplora una diversa sfumatura della paura. Uno degli apici della "passata stagione" di questa categoria filmica è sicuramente rappresentato dal film Creepshow (1982), in cui George Romero e Stephen King orchestrano un omaggio ai fumetti horror degli anni '50; ogni episodio è una gemma a sé stante che brilla di luce propria contribuendo, al tempo stesso, a illuminare il mosaico più grande. La tradizione continua fino ai giorni nostri con antologie come V/H/S (2012) o the ABCs of Death (2012), portmanteau nei quali registi provenienti da diverse culture e background si alternano in un'orgia di stili e visioni. Come ironicamente nota il regista Joe Dante, "è come un buffet dell'orrore: se non ti piace un piatto, puoi sempre passare al successivo". E questo è esattamente il valore aggiunto del portmanteau: un prodotto filmico che può riolversi fra il capolavoro e il pastiche (se non il disastro) ed ospitare, contemporaneamente, episodi memorabili al fianco di altri del tutto dimenticabili (Trilogia del Terrore, 1975). Comunque, in genere, difficile annoiarsi!

Pochi generi cinematografici hanno saputo catturare le ansie collettive con la stessa brutale efficacia del filone post-apocalittico. Pellicole di angosce esistenziali inscritte nell'era atomica, questi film danno iniio al racconto a partire dal momento nel quale, in genere, i racconti si interrompono. L'apocalisse, quindi, diventa l'inizio di una storia, ed è proprio questo che rende il genere così affascinante: non è tanto la fine del mondo a interessarci, quanto ciò che viene dopo. Dal seminale l'Ultimo uomo della Terra (1964) di Ragona e Salkow - con un Vincent Price magnificamente isolato in una Roma spettrale - fino all'enigmatico Stalker (1979) di Andrej Tarkovskij, il cinema post-apocalittico ha saputo trasformare le rovine della civiltà in potenti metafore della condizione umana. Come nota J.G. Ballard, questi "paesaggi della desolazione" diventano "mappe psichiche del nostro disagio contemporaneo". La tradizione australiana, con la sua "trilogia della rabbia su ruote" - Mad Max (1979) più seguiti e reboot - ha codificato quella che Peter Biskind ha definito "l'estetica della scarsità": un mondo nel quale la benzina o l'acqua valgono più del sangue, e la violenza è l'unica valuta corrente. George Miller ha creato quello che Pauline Kael definì "un western post-nucleare", in cui i cavalieri sono sostituiti da guerrieri della strada e i saloon da stazioni di servizio abbandonate. Non meno significativo è il filone del "contagio globale", legato a doppio filo con il genere Distopico, da l'Esercito delle 12 scimmie (1995) di Terry Gilliam a I Figli degli uomini (2006) di Alfonso Cuarón, dove la pandemia diventa specchio delle nostre angosce di connessione globale. In questi film, l'apocalisse non arriva dopo l'esplosione nucleare ma con il silenzioso diffondersi di un virus; una profezia cinematografica che, poi, la realtà ha reso fin troppo familiare. Il genere ha anche i suoi momenti di ironica autoriflessione: Apocalypse 2024 - Un ragazzo, un cane, due inseparabili amici (1975) di L.Q. Jones trasforma il racconto di Harlan Ellison in una dark comedy radioattiva, mentre la Jetée (1962) di Chris Marker - quello che Roger Ebert chiamò"un fotoromanzo del futuro passato" - diventa una meditazione sulla natura stessa del tempo e della memoria. E forse è proprio questa la chiave del successo duraturo del genere: in un'epoca di crisi ambientale, pandemie e tensioni nucleari, questi film non sono più semplici fantasie distopiche ma narrazioni che esprimono le nostre presenti paure.

Horror e Thriller psicologico sono categorie ben note in ambito cinematografico. All'interno di questo sito web, tuttavia, questo genere di pellicole assume un rilievo del tutto peculiare, soprattutto per interesse professionale. Il confine tra la mente umana e l'orrore è un territorio che il cinema ha esplorato con insistente fascinazione; d'altra parte, come osserva lo psichiatra e critico cinematografico Harvey Roy Greenberg in "Screen Memories", il cinema possiede una capacità unica di illuminare gli anfratti più oscuri della condizione umana, e non c'è anfratto più oscuro di una mente in preda alla follia. Già nei primi anni del '900, il cinema espressionista tedesco aveva intuito il potenziale perturbante della malattia mentale; il Gabinetto del dottor Caligari (1920) di Robert Wiene, con le sue scenografie distorte e l'ambiguità del suo protagonista, ha aperto la strada a un'esplorazione dell'inconscio che avrebbe influenzato generazioni di cineasti. Hitchcock ha fatto della psicopatologia il suo marchio di fabbrica: a partire da Psycho (1960), con il suo iconico Norman Bates e il suo insuperabile e insuperato Edipo, fino a Marnie (1964), un'incursione nella meccanica di trauma e regressione, il cineasta britannico ha dimostrato come il thriller possa diventare uno strumento di investigazione psicologica nonché di rappresentazione surreale-inconscia (Io ti salverò, 1945, con scenografie di Dalì), recuperando, in tal caso, la lezione di Wiene. Ma è, probabilmente, con l'avvento del "New Horror" degli anni '60 e '70 che il connubio tra psicopatologia e cinema raggiunse un apice di interessa da parte del pubblico. Se Rosemary's Baby (1968) di Roman Polanski e l'Esorcista (1973) di William Friedkin esplorano le angosce della maternità e dell'adolescenza attraverso il prisma del soprannaturale, il giallo all'italiana, soprattutto per merito di Dario Argento (ed influenza non indifferente di Mario Bava), fece della psicopatologia il motore primo della narrazione. Pellicole come Profondo rosso (1975) non sono solo mystery mozzafiato, ma anche dipinti a tinte forti di quadri caratteropatici se non francamente psicotici. Nello specifico, la categoria qui illustrata elenca non solo film nei quali i processi mentali si fanno centrali nello svolgimento narrativo ma pellicole per le quali la lettura psicologica e clinica consente di svelare, strato per strato, il senso recondito e simbologico del film. La categoria, quindi, non vuole semlicemente annoverare pellicole che narrano di "semplice" orrore psicologico o di folli mostri umani; nel nostro caso, la psicologia patologica assume una valenza centrale e la descrizione di essa, facilitata da competenze professionali, permette specifiche letture altrimenti impossibili od ostiche per chi non padroneggi le nozioni della psicodinamica, stando, comunque, ben attenti a non eccedere in interpretazioni forzose. Per gli appassionatissimi della psicodinamica, indico con una stella (★) le pellicole di maggiorata cifra psicologica e/o da me addizionate da riflessioni cliniche, cosa interessante per alcuni ma evitabile da chi non sia interessato alla cosa.

Uno dei territori più controversi della cinematografia di genere, un filone che emerge prepotentemente negli anni '70 come dark mirror delle tensioni sociali dell'epoca ed exploitation come può esserelo un genere che vede una donna vittima di violenza sessuale e, poi, arteficie di una tremenda vendetta ai danni di maschi verri che la pagheranno cara, la pagheranno tutta. Come osserva Carol J. Clover nel suo seminale "Men, Women and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film", questi film codificano, attraverso una narrativa estrema, le ansie della società patriarcale e la crescente consapevolezza femminista del periodo, benché il corpo della donna venga ancora esposto e reso obliquamente attraente. Proprio a questo proposito, il R&R si configura come un genere controverso perché il limite fra lo spunto critico legato alla violenza e quello voyeuristico, nonché una certa rappresentazione compiaciuta dell'assalto sessuale alla femmina, è innegabile. Vero anche che la vittima si fa velocemente eroina di un revenge-movie che riequilibra il meccanismo di dare e avere. Non violentate Jennifer (1978) di Meir Zarchi rappresenta il paradigma più noto del genere, seguito da opere come l'Angelo della vendetta (1981) di Abel Ferrara e Thriller - a cruel picture (1973) di Bo Arne Vibenius. Questi film, pur nella loro natura provocatoria, hanno contribuito a plasmare un sottogenere che Barbara Creed definisce "un'inversione radicale delle dinamiche di potere nel cinema horror tradizionale". La struttura narrativa tripartita - violenza, trasformazione, vendetta - riecheggia curiosamente gli archetipi del viaggio dell'eroe, seppur attraverso un prisma oscuro e disturbante. Come nota Alexandra Heller-Nicholas in "Rape-Revenge Films: A Critical Study", questi film, nella loro brutalità impossibile da accettare (e visionare) dallo spettatore medio, hanno paradossalmente contribuito a portare alla luce tematiche spesso relegate ai margini del discorso cinematografico mainstream. Il genere ha conosciuto diverse evoluzioni, dalle rivisitazioni più moderne e dinamiche, come Revenge (2017) di Coralie Fargeat, alle interpretazioni post-moderne come una Donna promettente (2020), dimostrando una sorprendente capacità di adattamento alle sensibilità contemporanee pur mantenendo il suo nucleo di critica sociale corrosiva.

Non per concedere "quote rosa", né per piaggeria. Indubbiamente, il cinema di genere ed horror (o il cinema in genereale, se visto dal lato tecnico) è dominato da un'operatività maschile. Altrettanto indubbiamente, vi è anche un buon numero di donne alle quali questo cinema interessa, piace, e ha desiderio e doti per realizzarlo. Emerge con forza crescente una costellazione di registe che hanno saputo implementare il genere attraverso una sensibilità distintiva e, in certi casi, a una progressiva ridefinizione dei codici dell'orrore. Si pensi a Kathryn Bigelow con i suoi vampiri de il Buio si avvicina (1987) - una fosca elegia sulla gioventù alienata dell'America reaganiana -; a Mary Lambert per la quale, in Cimitero Vivente (1989), il trauma della perdita familiare assume dimensioni lovecraftiane, Jennifer Kent, il cui Babadook (2014) dà forma mostruosa allo stess materno; Ana Lily Amirpour che con A Girl Walks Home Alone at Night (2014) fonde cinema iraniano con un più internazionale vampire-movie generando qualcosa di decisamente inusuale; concludendo con Coralie Fargeat e il suo the Substance (2024) che fa guadagnare al sottogenere body horror un Oscar. A parere di Barbara Creed, come scrive in "The Monstrous-Feminine", l'horror al femminile non si limita a ribaltare gli stereotipi di genere ma costruisce una grammatica visiva propria, per la quale il corpo - luogo privilegiato del terrore - diventa territorio di esplorazione politica; pensiamo ad American Psycho (2000) di Mary Harron che trasforma il serial killer yuppie di Bret Easton Ellis in una caustica allegoria del patriarcato finanziario; oppure a Karyn Kusama che, in Jennifer's Body (2009), gioca brillantemente con i tropi della teen-horror-comedy per costruire una feroce satira sulla mercificazione del corpo femminile. Tuttavia, sarebbe riduttivo parlare di un "horror femminile" come categoria monolitica. La questione non è tanto se esista uno "sguardo femminile" nell'horror, quanto come queste registe abbiano espanso i confini del genere generando un prodotto che non sia da giudicare tanto per il suo essere "femminile" o "maschile" ma per essere un buon film o meno. Sempre che lo si debba fare, sarebbe forse più interessante indagare l'eventuale diversa percezione del pubblico allo stimolo horror. Infatti, non è difficile concordare con quanto sosteneva la scrittrice Angela Carter: "Il vero horror non sta nei mostri, ma in chi li guarda"; forse, è proprio questo sguardo, multiforme e complesso, a rappresentare il vero contributo del mondo femminile al cinema dell'orrore.