


Il Ritorno dell'identico, rifacimenti, riproposizioni, revisioni o copie carbone. Perlopiù, si tratta di mere ragioni di portafoglio, perché logica vuole che ciò che ha funzionato un tempo, potrebbe altrettanto funzionare nel presente. Il fenomeno del remake rappresenta un'interessante forma di palinsesto culturale per la quale ogni nuova riscrittura aggiunge strati di significato al testo originale, anche se in effetti, come ha osservato ambiguamente il maestro del body horror David Cronenberg: "ogni remake è un fantasma che perseguita l'originale". Prendiamo come esempio la Cosa (1982) di John Carpenter, remake de la Cosa da un altro mondo (1951) di Christian Nyby: se l'originale incarnava le ansie della Guerra Fredda, la versione di Carpenter trasforma la paranoia del contagio in qualcosa che risuonava drammaticamente con il contagio da HIV che ai tempi preoccupava drammaticamente l'opinione pubblica. Oppure, consideriamo il remake Suspiria (2018) di Luca Guadagnino che trasfigura l'eccesso barocco di Argento in una meditazione sulla colpa storica e il potere femminile, quello che il critico James L. Hoberman ha definito "un remake che divora il suo genitore per acquisirne i poteri". Ma non tutti i morti ritornano con la stessa grazia! Per ogni the Ring (2002) di Gore Verbinski, che reinventa efficacemente l'originale giapponese per un pubblico occidentale, abbiamo dozzine di zombie cinematografici che sarebbe stato meglio lasciare nella tomba. Come nota sarcasticamente il critico britannico Mark Kermode: "alcuni remake sono come adolescenti che indossano i vestiti dei genitori: goffi tentativi di apparire maturi". Il reboot, cugino modernista del remake, promette di riavviare la macchina narrativa da zero; o almeno questa sarebbe l'intenzione, perché, non di rado certi reboot fanno rimpiangere persino i sequel più improbabili dei decenni precedenti. D'altra parte, soprattutto in campo horror, in tale eterno ritorno dell'identico si avverte il vero grande potere di questo genere cinematografico, ovvero il fatto di non poter mai essere sepolto; esso ritorna sempre, pur svilito, bistrattato e, in fondo, da sempre considerato junk food di cui si cibano persone intellettualmente poco acute. L'horror torna sempre, uguale a se stesso o con variazioni ma, comunque, incapace di esaurire l'esercizio narrativo delle sue storie e dei drammi che pare aver bisogno di mostrarci a ripetizione, forse perché noi stessi abbiamo un circolare bisogno di essere esposti ad essi.

Dal cinema exploitation, ovvero quello dello "sfruttamento" di situazioni spiate e descritte con lascivia ma, al contempo, condannate moralmente, emerge il Roughie (★) come evoluzione naturale del più ingenuo Nudie Cutie, film di nudità softcore che popolavano i drive-in americani (vedi Sexploitation). Mentre i nudies si dilettavano in innocue fantasie voyeuristiche, il roughie introduceva elementi di violenza e sadismo nella sua narrativa erotica, creando un sottogenere che flirtava pericolosamente con i confini del buon gusto e del Rating X. Registi come Doris Wishman (The Amazing Transplant, 1970) e Joseph P. Mawra (White slaves of Chinatown, 1964) elevarono questo format oltre le sue radici più rozze, intrecciando commentario sociale e psicologia contorta nelle loro opere. Il filone Women In Prison o, nel suo acronimo, WIP (★), d'altra parte, rappresenta uno dei più codificati sottogeneri dell'exploitation, con le sue convenzioni quasi ritualistiche: docce collettive filmante con studiata malizia (evoluzione tornbida dei nudies), sadiche guardiane in uniforme sovente lesbiche, rivolte carcerarie. Rientra chiaramente nel genere roughie e WIP il Naziploitation e, parzialmente, anche il Nunsploitation, sottogeneri ai quali viene dedicata una specifica sezione. Questi film, paradossalmente, mentre sfruttavano elementi voyeuristici, spesso incorporavano sottotesti sorprendentemente progressisti sulla corruzione istituzionale e l'oppressione femminile, benché in un'ottica erotizzata secondo i gusti eterosessuali maschili. Jonathan Demme, regista del ben noto il Silenzio degli innocenti (1991) iniziò la sua carriera con Caged Heat (1974), un WIP che, peraltro, sovvertiva le convenzioni del genere. Entrambi i filoni, WIP e Roughie, rappresentano un esempio, scarsamente attraente per il mainstream, di come il cinema exploitation, pur operando ai margini dell'industria cinematografica, riuscisse a processare e riflettere le ansie sociali del suo tempo attraverso il prisma della trasgressione commercializzata; questa riflessione può essere estesa al Torture porn, sottogenere horror-exploitation che deriva o è l'espressione moderna del Roughie.

La categoria di quel tizio che si dimentica sempre di fare i coperchi. Nel territorio qui etichettato "Satanic & Possession", luogo oscuro e di comprovato richiamo per il pubblico, esploriamo le manifestazioni più dirette e sinistre del Male assoluto attraverso due principali declinazioni narrative: la presenza fisica o metafisica di Satana e il fenomeno della possessione demoniaca. Questo filone cinematografico, che trova il suo paradigma moderno ne l'Esorcista (1973) di William Friedkin - "la più potente rappresentazione del Male come forza autonoma nel cinema contemporaneo" (Robin Wood) - si distingue nettamente da altre narrazioni soprannaturali per la sua peculiare focalizzazione sul confronto diretto tra il divino e il Male, tra la fede e l'abisso. A differenza dei film con presenze demoniache accessorie o strumentali - pensiamo alla dimensione action-comedy de la Casa 2 (1987) o alla componente splatter-demoniaca di Demoni (1985); (cfr. genere Demoniaco) - i satanic & possession movies si concentrano sulla natura stessa del Male come entità consapevole e sulla sua capacità di penetrare e corrompere l'anima umana; è proprio questa distinzione che rende Rosemary's Baby (1968) di Roman Polanski un capolavoro del genere: qui il Male non irrompe con clamore ma si insinua attraverso la normalità borghese, trasformando la maternità - simbolo per eccellenza della creazione - nel suo opposto diabolico. Dal film del '73 a l'Avvocato del Diavolo (1997), passando per Hereditary (2018), questa categoria esplora le molteplici sfaccettature della presenza satanica: dalla seduzione sottile alla manifestazione violenta, dalla manipolazione psicologica al confronto apocalittico. The Witch (2015) di Robert Eggers, ad esempio, recupera l'immaginario puritano per costruire un'atmosfera di paranoia religiosa che ricorda quanto il Male, nella tradizione occidentale, sia sempre stato percepito come intimamente legato alla trasgressione dei codici morali e sociali. Il tema della possessione, d'altra parte, come si trattasse di una categoria ben specifica di Body horror, fa del corpo "il terreno di uno scontro tra forze che trascendono la comprensione umana" (Carol J. Clover) trasformando il corpo posseduto in un campo di battaglia, metafora potentissima della perdita di controllo individuale (cfr. dinamiche del disturbo alimentare relativamente alla perdita del controllo del Sé). Interessante, inoltre, è il fatto che, generalmente, questi film affrontino il tema del divino attraverso la sua assenza o compromissione, appunto per intervento demoniaco, mettendo, quindi, in campo una narrativa che sembra voler parlare degli sforzi di sopravvivenza della fede in un mondo, il nostro, che si sta progressivamente ateizzando e relativizzando, con un primato dell'individuo sulla comunità che richiama molto facilmente il tropo dell'individualismo satanico e dell'Anticristo come leader sulle masse.

Categoria centrale nell'esperienza cinematografica in generale e di certo se in connessione con l'horror. Per evitare un elenco lunghissimo e ridondante, si è scelto di creare una categoria a sé per le le pellicole che vedono un medico o uno scienziato, più o meno folle, sperimentare contro le leggi di natura (Medical Horror), benché queste pellicole possano perlopiù essere fatte agilmente rientrare nel novero dei sci-fi-horror, anche detti fantahorror. Invece, si elencano qui sia i fantascientifici "puri", sia quelli con entità aliene (pur avendo una sezione a loro dedicata), sia i fantascientifici basati su paradossi di boot strap e spazio-temporali, nonché gli Hard Sci-Fi, genere anche detto Fantascienza Tecnologica, overo quella che pone enfasi sul dettaglio o l'accuratezza scientifica di ciò che viene descritto. Il fantascientifico-horror è un genere che ci ricorda come, nonostante tutti i nostri progressi tecnologici, o forse proprio per questi, il "buio" continui ad attendere proprio dietro lo schermo dei nostri computer. E forse è proprio questo il fascino del fantahorror: ci mostra che anche nel futuro più avanzato, le nostre paure più antiche trovano sempre un modo per raggiungerci. Il fantascientifico relativo ai paradossi spazio-tempo (★), d'altra parte, risulta essere in genere meno orrorifico ma tanto più stuzzicante intellettualmente con i suoi paradossi di bootstrap per cui la persona può divenire il genitore di se stesso. Questi film ci conducono attraverso labirinti narrativi in cui passato, presente e futuro s'intrecciano in modi sorprendenti e spesso sconcertanti, invitandoci a riflettere su questioni fondamentali: il libero arbitrio, la causalità e la natura stessa del tempo. A partire da pellicole quali la Jetée (1962) di Marker vengono stabiliti i canoni estetici e narrativi del genere, influenzando opere ben successive come Donnie Darko (2001) e Predestination (2014). La vera magia di questo sottogenere risiede nella sua capacità di combinare il rigore scientifico con la potenza della fantasia. Sul piano psicologico, essi paiono riflettere il nostro desiderio di correggere gli errori del passato, la paura del futuro incerto, la ricerca di un significato nel flusso apparentemente caotico del tempo. Dei temporal paradox sci-fi o chronological puzzle movies riconosciamo la loro natura ibrida che fonde elementi di thriller psicologico, Hard Sci-Fi con enfasi per il dettaglio tecnico, e dramma esistenziale in un'unica, complessa forma narrativa.
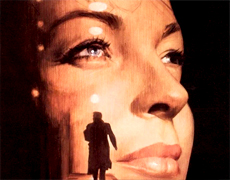
Non tutto l'amore cinematografico si gioca davanti a un tramonto o con una corsa all'eroporto. Una dimensione parallela nella quale il proverbiale "finché morte non ci separi" potrebbe essere solo l'inizio di una storia d'amore. Il soprannaturale può, in effetti, amplificare le dinamiche del desiderio fino a livelli vertiginosi; non è un caso che Angela Carter, brillante esploratrice del gotico, vedesse nel vampirismo la più potente metafora dell'amore ossessivo, fino al gelido romanticismo scandinavo di Lasciami entrare (2008), o al sentimento che torna dal passato e non ne vuole saper di abbandonarci di Fantasma d'amore (1981). Insomma, come ci ricorda il cult di Żuławski, Possession (1981), a volte l'amore più autentico è proprio quello che sfida ogni definizione di normalità. Nella sezione qui proposta, rientrano anche quelle pellicole che non necessariamente parlano di relazioni ed affettività, ma mostrano una decisa quota emotiva sia nella narrativa, sia nella volontà di muovere emotivamente lo spettatore.

Qui si esplora un'area sensibile ed ambivalente della psicologia umana: l'angoscia per la perdita dell'individualità all'interno del gruppo ma anche la ricerca di appartenenza al gruppo che, per alcuni, diventa paradossale desiderio di fusionalità e perdita di sé come individuo per onorare un valore superiore. Il cinema settario traduce questa dinamica in immagini viscerali, mostrandoci comunità dove la devozione si trasforma in controllo totale. Il genere, ovviamente, trova facile riscontro anche al fianco di pellicole appartenenti al novero dell'horror Demoniaco e al Folk Horror (es. the Wicker Man, 1973). Tuttavia, mentre l'horror demoniaco si concentra su forze soprannaturali esterne, l'horror settario interroga la capacità umana di autodistruzione attraverso la fede distorta. I film a tema settario tendono a condividere alcuni interessanti elementi ricorrenti: l'isolamento fisico e psicologico dei protagonisti, l'uso di rituali e simbolismi, l'esplorazione del trauma e della vulnerabilità emotiva, e la graduale rivelazione della vera natura delle comunità religiose rappresentate. Questo genere di film riflettono con onestà alcuni meccanismi documentati nei reali gruppi settari, il primo dei quali è che la violenza si maschera spesso dietro rituali di purificazione e bellezza, rendendo più difficile riconoscerne la natura distruttiva; così come, d'altrone, avviene anche per l'ideologia politica che consente tanta più violenza verbale e intolleranza quanto più riesce a mascherarla dietro un velo di impegno sociale e velleità filantropiche. Inoltre, l'isolamento settario è condizione necessaria per l'isolamento psicologico: i membri sono spesso allontanati dalle loro famiglie e dalla società, creando un ambiente in cui la manipolazione e il controllo diventano più facili. Questo isolamento fisico diventa metafora dell'isolamento psicologico, dove la comunità diventa l'unica realtà percepita, e ogni dubbio o critica viene silenziato attraverso la paura o la colpevolizzazione, motivo per cui i danni della manipolazione psicologica possono persistere anche dopo la fuga fisica dalla comunità. Il trauma, in questi casi, non è episodico ma strutturale, e coinvolge l'intera percezione della realtà. I film a tema settario o cultistico, insomma, offrono una buona occasione per esplorare temi profondi come il trauma, l'appartenenza e la manipolazione psicologica, mostrandoci versioni estreme di dinamiche che riconosciamo nelle nostre esperienze quotidiane: la pressione del conformismo, la seduzione dell'appartenenza incondizionata, la facilità con cui possiamo rinunciare al pensiero critico in cambio di certezze rassicuranti. Tutto ciò ci ricorda che il peggiore dei mali non si nasconde sotto il letto ma può nascere dalla nostra stessa necessità di credere, di appartenere, di trovare un senso.

Se l'exploitation è definibile come l'ampio bacino nel quale far rientrare i prodotti cinematografici low-budget che "sfruttano" (to exploit) temi scandalosi, controversi o semplicemente sensazionalistici a scopo commerciale, il sexploitation è la diramazione che, sempre in quell'ottica, ha fatto della sessualità un veicolo di licenziosità e provocazione. Tralasciando i primi roadshow, pellicole morbose ed erotiche portate per i paesi con tecniche che ricordavano i "medicine show" dei ciarlatani che viaggiavano per il farwest, l'exploitation fiorì fra la seconda metà degli anni '40 (Mom and Dad, 1945) e i primi '70 in risposta alle rigide restrizioni del codice censorio Hays, e quando i cinema indipendenti e i drive-in necessitavano di prodotti capaci di attirare spettatori senza poter competere con i colossal hollywoodiani. Nascevano così i grindhouse, sale cinematografiche malandate che proiettavano film low-budget caratterizzati da violenza esplicita, nudità e tematiche scandalose, non di rado mascherando il sensazionalismo dietro un'apparente funzione educativa: si pensi a Reefer madness (1936), un film che denunciava gli effetti devastanti della marijuana, oggi considerato un cult per la sua rappresentazione grottesca e caricaturale; oppure, i nudie-cuties (★). Questi ultimi, nacquero come evoluzione audace dei nudist film, pseudodocumentari che mascheravano il proprio contenuto erotico dietro una facciata di studio sulle comunità naturiste. Anche detti "nudies", questi film - durati circa un decennio da The Immoral Mr. Teas (1959) di Russ Meyer a Nine Ages of Nakedness (1969) di G.H. Marks - si caratterizzavano per la presenza di donne nude in contesti quotidiani, come spiagge o piscine, con deboli pretesti narrativi (magari inseguite da qualche bruto o mostro ma sempre con un taglio mai gravemente orrorifico) e con l'intento di intrattenere e provocare il pubblico maschile. La lettura sexploitation non fu, però, solo d'alleggerimento ma, innestandosi con il Crime ed il Noir andò a generare i Roughies caratterizzati da situazioni antisociali e atti violenti ai danni di donne (in sostanza, il papà del Torture Porn) e, da qui, le diramazioni WIP (Women in Prison), i Naziploitation e i Nunsploitation; quattro sottogeneri ai quali viene dedicata una sezione specifica. Da citare, ancora, nell'ambito exploitation i Ghoulies che combinavano horror ed erotismo (qui elencati fra gli Erotic Horror), fino a giungere agli skinflicks più espliciti di autori quali Russ Mayer (ma citiamo anche Not Tonight, Henry! del 1961 di W. Merle Connell, o Trader Hornee del 1970 di Jonathan Lucas) che hanno preparato la strada per la successiva rivoluzione del porno (vedi Hardcore). La peculiarità dei primi sexploitation, come detto, risiedeva nella loro capacità di mascherare contenuti trasgressivi sotto una patina di presunte finalità educative o documentaristiche, ciò permetteva di aggirare le rigide censure; a questo proposito fu paradigmatica la serie nata con Rapporto sul comportamento sessuale delle studentesse (Schulmädchen-Report: Was Eltern nicht für möglich halten, 1970) ma anche tante suggestioni veicolate dai precedenti film del genere Mondo. Registi come Meyer e Metzger hanno elevato il genere. se non attraverso una più sofisticata ricerca stilistica, almeno attraverso una lente artistica che emancipasse il sexploitation da un piano meramente commerciale e lo trasformasse in un veicolo di sperimentazione formale e critica sociale. La lezione sexploitation o, più generalmente, exploitation è, infine, stata colta da registi di maggior spessore; Quentin Tarantino ha costruito la sua poetica proprio sul recupero e la nobilitazione di questi codici espressivi, mentre Rodriguez o Rob Zombie, per citarne solo due, hanno dimostrato come l'estetica grindhouse possa dialogare con la sensibilità contemporanea. Moltissimi dei film visionati e presenti complessivamente sul sito hanno elementi sexploitation e potrebbero facilmente essere qui elencati; quindi, per limitare l'incusione e rendere la sezione più "rigorosa" si è preferito segnalare solamente le pellicole più chiaramente sexploitation anche per periodo storico produttivo, lasciando fuori quelle che pur mostravano elementi sessuali chiaramente finalizzati ad un facile richiamo per il pubblico.

Uno dei sottogeneri dell'horror di maggior successo al botteghino, un fiume di film che hanno fatto dell'omicidio seriale una forma d'arte quasi coreografica. Lo slasher è geometria della paura, un sistema di regole codificate quanto rassicuranti, nella loro prevedibilità, con Halloween - la Notte delle streghe (1978) di John Carpenter elevato da Robin Wood alla "perfetta cristallizzazione dell'angoscia giovanile nell'America suburbana". La formula è apparentemente semplice: un killer mascherato, spesso mosso da un trauma passato, perseguita un gruppo di adolescenti preferibilmente durante una festività o un'occasione speciale, eliminandoli uno ad uno con modalità sempre più creative, leggasi violente. Gli anni '80 rappresentarono l'età dell'oro dello slasher, con franchise horror di enormi successo, quali quella nate con Venerdì 13 (1980) o con Nightmare - Dal profondo della notte (1984), che trasformano la "death scene" in una performance omicidaria. Con lo slasher non viene solo elevata l'immagine del killer ma emerge anche l'archetipo filmico della "final girl", termine stato coniato dalla professoressa Carol J. Clover nel suo articolo "Her Body, Himself: Gender in the Slasher Film" (1987), ad indicare la "ragazza terminale", la depositaria dell'ordine morale, che riesce a sopravvivere al caos istintivo dello slash-killer grazie alla sua virtù che trova prova e sintesi nel suo essere ancora vergine in un ecosistema giovanile libertino e sciocco. Si consolidano, inoltre, le regole non scritte del genere: chi fa sesso muore, chi si droga muore, chi dice "torno subito" non tornerà. La svolta meta-cinematografica arriverà negli anni '90 con Scream (1996) di Wes Craven che vede personaggi consapevoli delle regole del genere e le commentano mentre le vivono, creando "un effetto specchio che riflette infinite volte la natura artificiale del terrore cinematografico" (Vera Dika). Il meta-slasher risolleverà tutto il mondo horror che si era affossato verso la fine degli anni '80 e i primi anni degli anni '90. Il nuovo millennio, comunque, ha visto ulteriori evoluzioni: da Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon (2006), mockumentary che decostruisce la figura del killer slasher, fino a Quella casa nel bosco (2011) che trasforma le convenzioni del genere in una complessa metafora sulla natura stessa dell'intrattenimento horror. Lo slasher contemporaneo, insomma, pare dirci che nel nuovo millennio la consapevolezza del meccanismo narrativo è diventata parte integrante del piacere spettatoriale, finendò, però, per impoverire il carattere emotivo dell'horror viscerale e spingendo verso un intellettualizzazione del genere che non sempre si mostra "elevated" come vorrebbe.

Il territorio del paranormale ma non del demoniaco o del fantasmatico, mondi che hanno una loro specifica sezione. Qui albergano pellicole come the Mothman Prophecies (2002), racconti di fenomeni e avvistamenti inspiegabili, ed esperienze ai confini del possibile che diventano potenti metafore della nostra ansietà contemporanea. Non si tratta solo di raccontare storie inquietanti, ma di esplorare quella sottile linea che separa il documentato dall'incredibile, il possibile dall'impossibile. Tra il visionario, il dispercettivo e le memorie traumatiche, questi film, come osserva acutamente Linda Badley nel suo libro "Film, Horror, and the Body Fantastic", rappresentano una particolare sottocategoria dell'horror che si nutre della nostra innata incertezza sulla natura stessa della realtà. In questi lavori, generalmente, non troviamo il conforto delle convenzioni horror tradizionali: non c'è sangue né mostri nascosti nell'armadio, solo quella sottile e persistente sensazione che il tessuto stesso del quotidiano possa strapparsi in qualsiasi momento, rivelando qualcosa di altro. È quella sensazione che Jeffrey Kripal, studioso di fenomeni paranormali, definì il "super-naturale": non tanto il soprannaturale delle favole, quanto, piuttosto, un'espansione inquietante dei confini del reale. In questa sezione, dunque, precipitano quelle pellicole per le quali il paranormale diventa, paradossalmente, il modo più lucido per esplorare i nostri dubbi più profondi sulla natura dell'esistenza stessa.

Il Giallo all'italiana rappresenta uno dei più affascinanti risultati d'imbridazione nella storia del cinema: un'alchimia unica per la quale il thriller psicologico hitchcockiano incontra la tradizione del Grand Guignol, il tutto filtrato attraverso una sensibilità tipicamente italiana che ha privilegiato la messa in quadro rispetto all'arzigogolo del mystery più classico, trasformando la violenza in una danza macabra di straordinaria bellezza formale. Questo sottogenere che ancora funge da materiale d'ammirazione per i cinefili di tutto il mondo, e d'ispirazione per i nuovi cineasti, nasce dall'intersezione tra la letteratura pulp dei romanzi gialli Mondadori e una peculiare estetica cinematografica che trova in Mario Bava il suo primo grande architetto. La Ragazza che sapeva troppo (1963) e Sei donne per l'assassino (1964) stabiliscono i codici visivi del genere: killer di nero vestito e gauntato, omicidi elaborati, motivazioni psicopatologiche dietro l'agire ma anche una prassi "maligna" specchio di quella patologia, una fotografia iperestilizzata che trasforma ogni goccia di sangue in un rubino scintillante. Ed è con Dario Argento che il giallo raggiunge il suo apice barocco. L'Uccello dalle piume di cristallo (1970) segna quello che Roberto Curti definisce "il momento in cui il thriller italiano diventa consapevolmente opera d'arte". La trilogia degli animali - completata da il Gatto a nove code (1971) e Quattro mosche di velluto grigio (1972) - stabilisce un nuovo paradigma per il quale, come osserva Maitland McDonagh in "Broken Mirrors/Broken Minds", "la soluzione del mistero diventa secondaria rispetto all'orchestrazione della suspense come esperienza puramente sensoriale". La forma apicale del giallo argentiano la si avrà con Profondo Rosso (1975) asceso, almeno su territorio nazionale, da spettacolo filmico a pezzo di cultura popolare, finanche relativamente al titolo. Altri registi, come Pupi Avati (il suo la Casa dalle finestre che ridono, 1976, è l'altro grande zenit del genere), Umberto Lenzi, Sergio Martino e Lucio Fulci, in base alla loro sensibilità, faranno dello Spaghetti Giallo una dimensione di critica sociale mascherata da exploitation o esploreranno zone marginali e più estreme del genere, chi accentuando la dimensione splatter, chi quella del bizzarro, chi la dimensione erotica. Il Giallo all'italiana rimarrà, in ogni caso, "un genere perpetuamente in bilico tra arte e artificio, tra virtuosismo tecnico e eccesso gratuito" (Gary Needham). Ma sarà proprio questa tensione irrisolta a renderlo così affascinante: un cinema che trasforma i suoi limiti produttivi in virtù stilistiche, in cui anche le trame più improbabili diventano pretesti per straordinari esercizi di stile, e l'omicidio diventa pretesto per una riflessione sulla natura stessa della visione cinematografica, cioè la scopofilia dello spettatore. La categoria comprende sia i classici giallos di stampo argentiano, sia i thriller più tipici del decennio Sessanta; si è evitata una separazione fra questi due generi poiché, in molti casi, vi è una sovrapposizione di temi e stili di rappresentazione, così come avviene con il poliziottesco-giallo, l'etruscologico (giallo-fantasy), il giallo ereditario con sequenze splatter. Peculiare fusione, quasi tutta italiana, tra erotismo softcore e le convenzioni del giallo-thriller è il Sexy-Giallo(★). Questo sottoprodotto rappresenta un curiosissimo esperimento di ibridazione cinematografica emerso quando i produttori italiani, sempre attenti alle tendenze del mercato, decisero di sposare la tensione psicologica del giallo, quella connessa a Thanatos, in direzione di Eros, rivangando una delle più classiche dualità. Il risultato? Un cocktail che miscela sapientemente elementi apparentemente inconciliabili: l'estetica patinata del thriller, completo di killer e lame scintillanti, con scene di seduzione e nudità più o meno esposte. Ciò che rende il Sexy Giallo particolarmente affascinante è la sua natura intrinsecamente contradditoria: da un lato cerca di mantenere la sofisticatezza visiva e narrativa del giallo classico, dall'altro si concede ampie digressioni erotiche che spesso rasentano il ridicolo. È proprio questa tensione irrisolta tra aspirazioni artistiche e necessità commerciale ed exploitation a renderlo un genere così significativo. Registi come Sergio Martino e Umberto Lenzi furono tra i principali artefici di questa peculiare commistione, creando opere che oscillano tra suspense e sensualità, al punto da definire un certo tipo di giallo erotico, il "Giallo Lenziano". Le protagoniste femminili - Edwige Fenech, Barbara Bouchet, Carroll Baker, per citare solo il tridente più noto - diventarono vere icone del genere, portando sullo schermo un mix di vulnerabilità e sensualità che definì l'estetica del filone.

Lacerazione? Là c'era azione! Lo splatter può essere ferro (ultragore, in una sezione specifica) o può essere piuma (splatterstick, ovvero lo splatter comico); ad ogni modo, rappresenta una delle espressioni più viscerali e transgressive dell'horror, un sottogenere che ha ridefinito i confini della rappresentazione della violenza sul grande schermo. Emerso dalle viscere della controcultura cinematografica degli anni '60, lo splatter ha fatto della carneficina grafica la sua cifra stilistica distintiva, elevando gli effetti speciali pratici a forma d'arte. Questa peculiare declinazione cinematografica affonda le sue radici nel Grand Guignol parigino, il teatro dell'orrore che, già all'inizio del '900, scioccava gli spettatori con le sue rappresentazioni sanguinose. Ma è con il pionieristico ed exploitation Blood feast (1963) di Herschell Gordon Lewis che il genere trova la sua codificazione moderna, inaugurando quella che gli studiosi hanno definito la "trilogy of gore", insieme a Two thousand maniacs! (1964) e Color me blood red (1965). Lo splatter si nutre di una particolare tensione psicologica: da un lato cerca di respingere lo spettatore con la sua brutalità esplicita, dall'altro lo attrae per la nostra connaturata compulsività a guardare - ciò che fa la totale fortuna dei social! - ad ispezionare esteriormente ciò che, per sua natura, è sempre nascosto alla vista. Non è un caso che registi come Lucio Fulci abbiano elevato questa dialettica a cifra autoriale, con l'occhio deorbitato come simbolo assoluto di questo processo, in quanto strumento della visione e, al contempo, organo anatomico visibile in tutta la sua rotondità solo se cavato dal suo cavo orbitale. In un'epoca di effettistica digitale pervasiva, poi, il cinema splatter, quello più artiganale fatto ancora di protesica e sangue finto, mantiene un fascino particolare proprio per la sua tangibilità, per quella dimensione tattile degli effetti speciali che, paradossalmente, rende l'irreale più credibile attraverso la sua materialità. Un tempo, materiale per spettatori smaliziati e coraggiosi, oggi lo splatter è stato sdoganato e, seppur non apprezzato da tutti, è tollerato dal mainstream. Cosa diversa per l'Ultragore, o ultra-splatter, che merita una sezione a sé.

I film horror devono fare paura? Non necessariamente. Tuttavia, la capacità di un film horror di atterrire tramite jump scares (i proverbiali balzi sulla sedia), o costruendosi come spooky fest (termine coniato dal critico David Edelstein per descrivere film costruiti come elaborate macchine di tensione e spavento), oppure tramite situazioni perturbanti, è un fattore popolarmente richiesto al genere. Vi sono, poi, horror capaci di creare disagio anche dopo la visione, a schermo spento. Questa particolare declinazione del genere horror, che trova le sue radici nel "cinema delle attrazioni" teorizzato da Tom Gunning, si è evoluta in un meccanismo di gratificazione calcolata: una costruzione narrativa fatta di inquadrature studiate e movimenti di macchina che suggeriscono minacce imminente che manipolano sapientemente il ritmo della tensione per culminare in momenti di shock calibrati con precisione matematica. La costruzione delle sequenze di tensione segue un pattern preciso, un momento di sincronizzazione fra suono e immagine per creare uno shock sistemico che il pubblico contemporaneo ha imparato a desiderare quasi pavlovianamente. I film del terrore, idealmente diversi dai film dell'orrore che instillano ribrezzo e non paura, si affinano in una continua ricerca della formula perfetta per provocare una risposta di soprassalto potenziata. D'altra parte, quanto un horror possa far paura è un fattore molto soggettivo, perché la paura è un meccanismo che suona la sua terribile melodia tramite tasti più inconsci che consci. Quindi, prendete questi miei suggerimenti come un'indicazione di carattere soprattutto personale. Per chi fosse curioso di sapere quali, fra le pellicole visionate, hanno spaventato o sono rimaste incollate alla mente di un horror fan non esattamente di primo pelo, si guardino le stellate (★).

Pellicole stregonesche, di magia, sabba e caccia alla spose di Satana, una delle più durature manifestazioni dell'inquietudine patriarcale verso il potere femminile autonomo. La rappresentazione cinematografica di maghi e streghe ha attraversato molteplici metamorfosi: dalla documentaristica crudezza espressionista di la Stregoneria attraverso i secoli (Häxan, 1922) di Benjamin Christensen - il primo tentativo di analisi pseudo-antropologica del fenomeno - fino alle rivisitazioni femministe (la Stagione della strega , 1972, di George A. Romero) e post-femministe (le Streghe di Salem, 2012), nelle quali la strega diventa, per usare le parole di Angela Carter, "un simbolo di resistenza culturale". Affascinante, almeno per il cinefilo italiano, come il nostro cinema degli anni '60 e '70 abbia codificato una propria peculiare visione della stregoneria tramite opere come la Maschera del demonio (1960) di Mario Bava, nelle quali l'estetica gotica si fonde con una sensualità tipicamente mediterranea che, negli anni successivi, troverà maggior declinazione nell'erotic horror e nell'exploitation con sottolineatura della cornice sadica. Il tema della stregoneria ha dimostrato una notevole resistenza anche nel cinema contemporaneo, evolvendosi in quello che la studiosa Alexandra Heller-Nicholas definisce "witch-core": un sottogenere che fonde elementi folk horror con una sensibilità decisamente attuale, come evidenziato in opere quali the Witch (2015) o Hagazussa (2017), film per i quali l'accuratezza storica diventa strumento di straniamento psicologico. La strega, ancor più dello stregone (contemplato in questa sezione), affascina come archetipo della nemesi dell'altro archetipo femminile, quello della vergine generatrice, la Eva sottomessa ad Adamo: la strega, progenie di Lilith (la prima donna che rifiutò Adamo, ovvero il giogo maschile), è sterile, sterilizza le messi, uccide e divora i bambini, gode della sessualità e si trasforma in bellissima creatura a fini seduttivi, pur pagando la colpa per il suo matrimonio con Satana divenendo, questo il suo vero aspetto, un'orribile emarginata. Creatura dannatamente eroica e, quindi, passibile di un fascino intramontabile.

Il torture porn e, soprattutto, il fenomeno dello pseudo-snuff rappresentano quello che il teorico del cinema James Kendrick ha definito "il punto di rottura dell'etica rappresentativa", un territorio cinematografico in cui il confine tra finzione e documentazione si dissolve in un inquietante gioco di specchi. Snuff (1975) dei coniugi Findlay, figlio dei Roughie di un decennio prima (cfr. con genere in questa stessa pagina), rappresenta un affascinante caso di studio di come la mitologia urbana possa infiltrarsi nel tessuto della produzione cinematografica, elevando di parecchi gradi il marketing della trasgressione; la studiosa Linda Williams, nel suo fondamentale "Hard Core: Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible", fa notare come questo film abbia codificato, involontariamente, l'intera estetica della "morte autentica simulata". Il torture porn contemporaneo ha ereditato questa ambigua relazione con il reale portandolo a livelli sueriori di iper-realismo. Film come Hostel (2005), pellicola per la quale critico David Edelstein, nel 2006, coniò il termine "torture-porn", danno rappresentazione, così come avviene con il body horror, ad una violazione del corpo metafora di ansie sociali più profonde, e non stupisce, in quest'ottica, che il genere fiorisca dopo l'11 settembre 2001. Il torture porn, dopotutto, sviluppa una fenomenologia del disgusto, in quanto esperienza cinematografica che si rivolge non tanto all'intelletto quanto alle viscere dello spettatore; come dire che agisce sul somatico sia nella sua dimensione rappresentativa, sia in quella comunicativa. La visione del torture-porn, il più delle volte scarsamente consigliata e ancora meno necessaria, si fa esplorazione dei "limiti dell'esperienza rappresentabile", come direbbe Bataille, un viaggio attraverso quello che potremmo definire il lato oscuro dell'immaginazione cinematografica. Si ricorda, benché non dovrebbe esserci la necessità di specificarlo, che l'autore di questo sito non nutre nessun interesse o attrazione per ciò che non sia finzione filmica o, se rappresentazione del reale, che essa sia inscritta in qualche cornice narrativa; non ho mai visionato, né ho interesse a visionare, filmati snuff reali.

Il cinema ha il potere unico di trasportarci in mondi diversi ma poche cose colpiscono la fantasia dello spettatore come il sapere che il racconto offerto dal film è tratto da una storia vera, seppure, spesso, solo in modo vago o decisamente creativo. Con il meccanismo del "tratto da una storia vera", entriamo in quello che Bill Nichols ha definito "il territorio dell'indentità negoziata" - uno spazio in cui il reale viene simultaneamente documentato e drammatizzato, creando quello che lo psicoanalista Christian Metz definiva un "surplus di credenza", ovvero, da parte dello spettatore, un investimento emotivo amplificato dalla consapevolezza della matrice fattuale della narrazione. In questa categoria, nella quale facciamo rientrare anche i film d'impianto verité, si riflette, in qualche modo, l'idea della "redenzione della realtà fisica" espressa dal teorico Siegfried Kracauer, cioè che il cinema possa, attraverso determinate scelte stilistiche, avvicinarsi a una forma di verità che trascende la semplice documentazione degli eventi. D'altra parte, la costante tensione fra fedeltà storica e necessità drammaturgica impedisce di mantenere l'autenticità dell'evento originale, la quale autenticità, forse, non ci interessa per quanto riguarda il cinema - e pare impossibile anche per la documentaristica e persino per il giornalismo - che è un mezzo che non si limita a registrare il reale ma lo interpreta, lo plasma e, talvolta, lo rivela in modi che la semplice cronaca non potrebbe mai raggiungere.

Il twist ending, "il punto di rottura del contratto narrativo" (David Bordwell), è il momento in cui tutte le coordinate della narrazione vengono improvvisamente ridisegnate, creando quello che gli psicologi cognitivisti chiamerebbero una "dissonanza cognitiva". Non si tratta semplicemente di un espediente narrativo, ma di una vera e propria architettura del disorientamento che richiede una determinata precisione nella sua costruzione di questi colpi di scena. Se posto a confronto con le meccaniche del giallo, anch'esso teso ad uno svelamento finale inaspettato, il twist ending mira ad un rovesciamento: il giallo svela gradualmente una verità nascosta, il secondo, invece, opera una vera e propria riconfigurazione della realtà narrativa. L'arte del "colpo di coda" funziona come una sorta di trauma narrativo controllato: uno shock che non solo sorprende lo spettatore ma lo costringe a riconsiderare l'intero apparato di significati costruito fino a quel momento. Ciò porta, non di rado, alla necessità, o persino al piacere, di una seconda visione che lo storico del cinema Thomas Elsaesser definì "la narratologia della retrospezione": il piacere paradossale di riguardare un film sapendo già il suo segreto per scoprirne i codici nascosti. D'altra parte, il twist ending si presta anche al rischio di forzatura, alla sindrome del deus ex machina post-moderno, ovvero la tentazione di stupire a tutti i costi, sacrificando la verità strutturale della storia sull'altare dell'effetto shock.

Esplorazione dell'abietto che va oltre la semplice provocazione, l'Ultragore vive in un territorio in cui il confine tra arte e trasgressione si dissolve in un insieme di immagini viscerali che sfidano i limiti della rappresentabilità, quella che il teorico del cinema Jack Stevenson definisce "zona zero della rappresentazione", dove la violenza grafica trascende la sua funzione narrativa per diventare pura esperienza sensoriale. Questi film si distinguono dal tradizionale splatter, già per molti eccessivo, per la loro approccio quasi clinico alla materia, reminiscente delle fotografie post-mortem di Alphonse Bertillon. Come ha notato la studiosa Linda Williams nel suo "Hard Core: Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible", l'ultragore cerca di catturare quello che lei chiama "l'eccesso infilmabile", spingendosi oltre i confini del tabù fino a giungere all'impossibile della rappresentazione. Il cortometraggio Aftermath di Cerdà, ad esempio, con la sua meticolosa esplorazione della necrofilia attraverso lo sguardo clinico di un anatomopatologo, evoca inevitabilmente un vissuto perturbante che emerge quando il familiare (in questo caso, il corpo umano) diventa fonte di orrore indicibile. Non mancano, tuttavia, letture ironiche in campo ultragore - potremmo dire ultrasplatterstick - come quella offerta da Peter Jackson con Braindead (1992). Questi film, in sintesi, trasformano l'orrore corporeo in una forma d'arte estrema che sfida non solo i limiti della censura ma anche quelli della nostra capacità di elaborare il traumatico visivo.

Sangue e celluloide: l'eternità del Vampiro nel cinema. Nel pantheon dei mostri cinematografici, quelli definiti "classic monsters", i primi attenzionati dal cinema horror, il vampiro siede sul trono ed ha trasceso sia la semplice categoria horror, sia l'attenzione dei soli appassionati di horror, finendo per conquistare le simpatie del pubblico mainstream. Nell'aver attraversato più di cento anni di cinema, questo mostro sacro ha anche mutato aspetto e stili rappresentativi; come osservò la professoressa Nina Auerbach in "Our Vampires, Ourselves" (1995), ogni epoca crea i vampiri che merita, e il cinema, fin dai suoi albori, ha saputo trasformare questa creatura proteiforme in uno specchio delle nostre paure, desideri e ossessioni collettive. Si va, dunque, da Nosferatu (1922) di F.W. Murnau - quella rapsodia espressionista delle ombre che James Marriott definisce "il primo grande poema gotico del cinema" - fino alle recenti interpretazioni post-moderne e femministe (Nosferatu, 2024, di Eggers). Il conte Orlok del '22', con la sua silhouette da incubo mitteleuropeo, sembra l'antitesi del romantico Dracula (1931) interpretato da Lugosi, incarnazione dell'aristocratico decadente al contempo minaccioso e seducente. La Hammer britannica, poi, porterà il vampiro nel mondo di un sanguinolento technicolor: la presenza magnetica di Christopher Lee ha riscritto il canone vampirico negli anni '50 e '60: Dracula il Vampiro (1958) segna quello che il critico e sceneggiatore David Pirie definisce "il momento in cui il gotico vittoriano incontra la sensualità della controcultura", creando un paradigma che influenzerà generazioni di cineasti. Insomma, come detto, Il vampiro cinematografico è un prisma attraverso cui si rifrangono ansie e valori sociali di ogni epoca: la paura del contagio in Io sono leggenda (1964), la metafora della dipendenza in the Addiction - Vampiri a New York (1995) di Abel Ferrara, l'alienazione adolescenziale in il Buio si avvicina (1987) di Kathryn Bigelow; non è un caso, quindi, che Carol J. Clover abbia definito il vampiro cinematografico come "l'ultimo significante fluttuante dell'horror, capace di incarnare qualsiasi angoscia culturale". Consapevole del proprio fascino e biografo di sé stesso (Intervista col vampiro, 1994), il Succhiasangue è un predatore-seduttore, teatrale, performer, e ciò sembra essere la chiave di volta che regge l'attrazione che esercita su un pubblico tanto trasversale; ogni sua mutazione filmica, che va dall'arcano non-morto al romantico adolescente liceale, aggiungono un nuovo strato al significato, un nuovo tassello per un mostro cinematografico capace di adattarsi come nessun altro.

Beneamata categoria filmica qui su exxagon.it. La categoria sotto la cui stella, questo sito nacque nel 2004. Il cinema inusuale, quello della stranezza, della bizzarria, del percorso che si discosta dal cinema più comune, più frequentato, il mainstream. Un viaggio nel territorio del "weird cinema" richiede un abbandono consapevole delle nostre coordinate narrative tradizionali. Questo genere di pellicole, se di genere possiamo parlare, comunica tramite una grammatica non convenzionale: dal surrealismo provocatorio di Luis Buñuel, che in un Chien Andalou (1929) sconvolge gli spettatori con il rasoio che taglia l'occhio della ragione, fino all'onirico "delirio industrial" di David Lynch in portato sugli schermi con Eraserhead (1977); o il caleidoscopico viaggio di Holy Motors (2012) offertoci da Carax; o l'irriverente Kung Fury (2015) che trasforma la nostalgia degli anni '80 in un frullato psichedelico di dinosauri, nazisti e hacker temporali. Un territorio in cui Possession (1981) di Żuławski può coesistere con House (1977) di Nobuhiko Ōbayashi, luogo in cui il surreale non è un'eccezione ma la regola, e dove, come diceva André Breton, "il meraviglioso è sempre bello, qualsiasi meraviglioso sia bello, anzi non c'è che il meraviglioso che sia bello". Questa dimensione artistica si configura come un autentico baluardo contro l'egemonia del racconto convenzionale e, più ampiamente, contro quella sensibilità piccolo-borghese che pretende di travestire da innovazione ciò che rimane, in sostanza, profondamente conformista. È come se questi film avessero il coraggio di denunciare l'impostura di chi si atteggia a rivoluzionario senza possedere alcuna vera forza eversiva. Il cinema del bizzarro non rappresenta tanto un genere cinematografico quanto piuttosto uno stato dell'anima creativa. Si tratta di un'indole ribelle che sa distinguersi dalla mera provocazione adolescenziale o dal capriccio distruttivo fine a se stesso; non si limita a contestare l'autorità costituita per principio, ma ambisce a diventare fertile generatrice di linguaggi inediti e paradigmi alternativi. In questo elenco troverete, fra i film da me visionati, quelli che albergano elementi di peculiare stranezza sia rappresentazionale sia narrativa e, fra essi, quelli segnalati da una stella (★) saranno, fra i bizzarri, quelli più bizzarri, alcuni al limite della incomprensibilità, film per i quali l'esperienza sensoriale può diventare del tutto prioritaria rispetto all'impianto narrativo.

In quella terra di nessuno in cui i fantasmi cavalcano al tramonto e i revenant indossano il poncho, l'horror-western ha creato uno degli incroci più curiosi della storia del cinema, la commistione fra due territori di frontiera, quella degli Stati Uniti dell'ovest e i territori metafisici dell'ignoto. Da l'Uomo senza corpo (1959), curiosa anomalia Universal che trasformava i vampiri in pistoleri, fino al più recente Bone Tomahawk (2015), in cui Kurt Russell affronta cannibali trogloditi nel far west, il genere ha sempre giocato con quella che Carol J. Clover definisce "la sottile linea tra wilderness fisica e soprannaturale" raccontando la mitica violenza della frontiera attraverso il prisma del soprannaturale. Billy the Kid vs Dracula (1966), nonostante o forse proprio per la sua deliziosa assurdità, rappresenta un esempio quasi perfetto della collisione fra l'archetipo del vampiro aristocratico europeo contro l'individualismo selvaggio della frontiera americana e, in senso lato, del mondo cinematografico horror con quello western. Una dicotomia ripresa e sovvertita in il Buio si avvicina (1987) di Kathryn Bigelow, film in cui i vampiri sono proprio quei cowboy che, un tempo, popolavano il West. In questo territorio ibrido, trovano spazio anche i portmanteau (Grim Prairie Tales: Hit the Trail... to Terror, 1990) e persino gli zombie trovano il loro spazio naturale, come dimostra the Quick and the undead (2006). Un sottogenere poco frequentato, anche perché strettamente connesso alla tradizione statunitense, tuttavia interessante proprio per la sua relativa rarità.

Zombi, ovvero il mondo apocalittico abitato da defunti che torneranno a camminare sull Terra quando all'inferno non ci sarà più posto. Pochi mostri del cinema hanno avuto tanta fortuna come il morto-vivente; esso è il mostro democratico per eccellenza; come suggerisce Kyle William Bishop in "American Zombie Gothic", chiunque può diventare zombi, chiunque può esserlo. Dal voodoo haitiano de l'Isola degli zombies (1932) fino all'apocalisse virale contemporanea (28 giorni dopo, 2002), questo instancabile revenant continua a divorare il nostro immaginario collettivo. George A. Romero, con la Notte dei morti viventi (1968), ha riscritto il codice genetico del genere, trasformando lo zombi da schiavo del voodoo in metafora ambulante del consumismo americano, una lettura che Robin Wood definisce "la più spietata critica della società americana mai emersa dal cinema di genere". Il suo secondo capolavoro Zombi (Dawn of the Dead, 1978) porta questa metafora nel tempio stesso del consumismo: il centro commerciale in cui i morti viventi vagano come parodie grottesche dei consumatori moderni. Gli zombi sono diventati un prisma attraverso cui rifrangere le ansie sociali di ogni epoca: il conformismo suburbano nel film del '68', il consumismo sfrenato nella pellicola del '78', la divisione di classi sociali ne la Terra dei morti viventi (2005). Persino l'irriverente l'Alba dei morti dementi (2004) usa i morti viventi per commentare l'alienazione della vita moderna. Il genere ha dimostrato una straordinaria tenacia, reinventandosi continuamente, dai non morti lenti e goffi, a quelli frenetici; dagli zombi divenuti tali non si sa bene perché, a quelli vittima di magia, di influenza satanica, derivati da esposizioni a tossine o virus. Queste creature sembrano incarnare il rimosso che ritorna e ritorna ancora, facendo riaffiorare, da un terreno mortifero, la disumanizzazione e la paura ancestrale dell'altro come portatore di contaminazione; interessante, a questo proposito, leggere il non-morto secondo una chiave proiettiva e paranoidea, così come è per lo xenomorfo di Alien (1979). Tra l'altro, in un'epoca post-pandemia e che ha esperito il distanziamento sociale, il cinema zombi ha acquisito una nuova, inquietante risonanza, facendo del non-morto una creatura, come vaticinato da Romero, "più viva dei vivi". E i successo delle serie tv a tema zombi, così come i videogame dello stesso tema, parlano chiaro circa il fatto che non solo il non-morto continua ad affascinare il pubblico, ma affascina anche la combinazione di esso con il genere post-Apocalittico e il folklore legato al survivalism e ad un mondo nuovo, resettato, che sembra offrire implicitamente l'opportunità di ripartire da zero. Il genere zombi, insomma, fra possibilità di uccisioni impunite ed esplorazioni per una "nuova casa" sembrano lasciare trasparire rabbia e frustrazione per una vita che va troppo stretta.